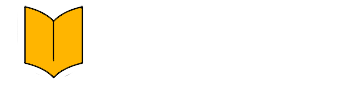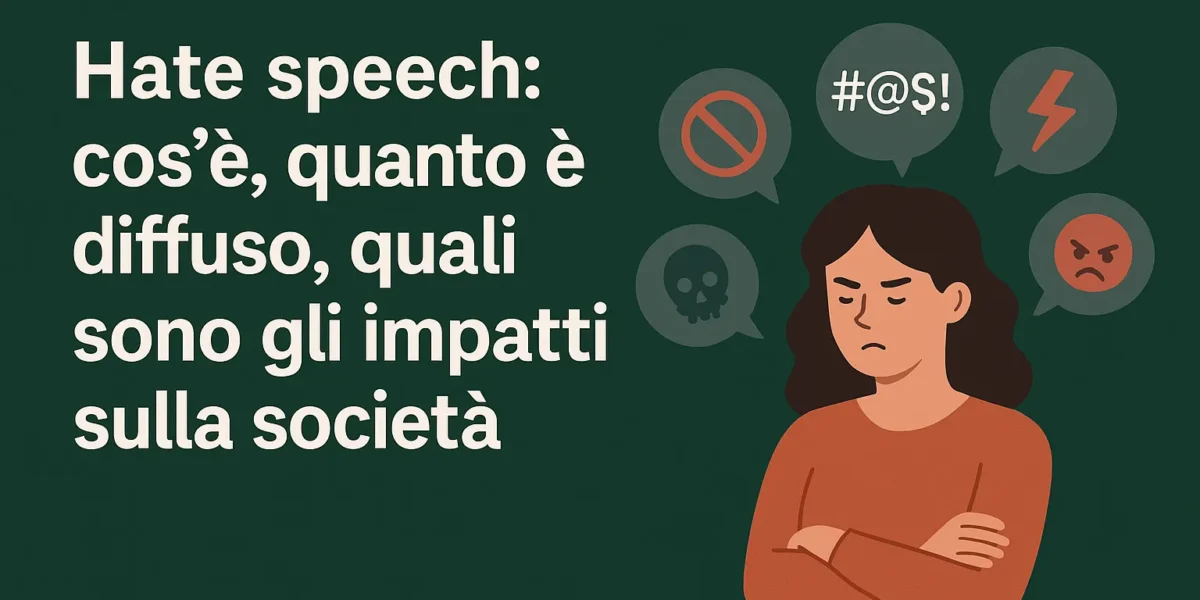Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione digitale è ovunque. I social network, i blog, i forum e le piattaforme online influenzano profondamente il modo in cui formiamo opinioni, costruiamo relazioni e viviamo il dibattito pubblico. In questo contesto, il fenomeno dell’hate speech, ovvero il linguaggio d’odio, rappresenta una delle principali minacce alla convivenza civile e alla libertà d’espressione.
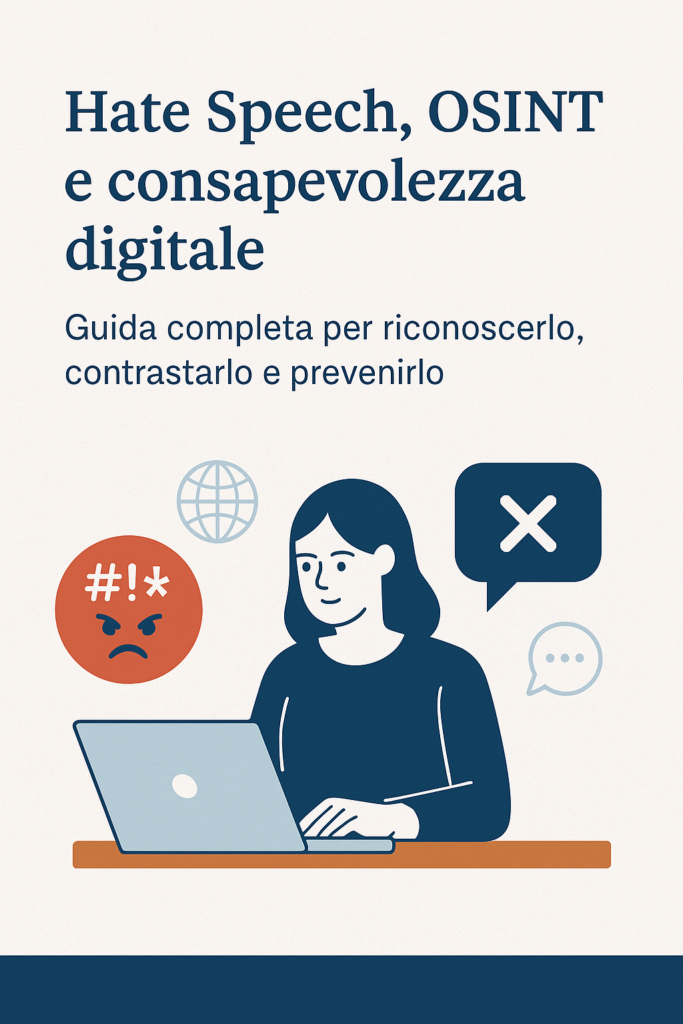
Cos’è l’Hate Speech secondo il Consiglio d’Europa
Secondo il Consiglio d’Europa, si definisce hate speech l’istigazione, promozione o incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione contro individui o gruppi sulla base di caratteristiche come razza, sesso, religione, convinzioni personali, disabilità o orientamento sessuale. Questo tipo di linguaggio è spesso veicolato dalle stesse piattaforme che ogni giorno utilizziamo per informarci o comunicare.
Stereotipi e discriminazione: cosa ci dicono i dati
Secondo Amnesty International, stereotipi e pregiudizi sono il terreno fertile su cui nasce l’odio. La ricerca ISTAT del 2018 ha messo in luce la persistenza di credenze preoccupanti, come quella secondo cui una donna che subisce violenza sessuale avrebbe una qualche responsabilità. L’Eurobarometro 2019 ha inoltre rilevato che in Italia la percezione della discriminazione è più alta della media europea, a dimostrazione della centralità del tema.
Chi si occupa di comunicazione e giornalismo deve tenere conto di questi dati. In proposito, è utile leggere l’approfondimento su Diventare Giornalista: l’era della comunicazione e la lettura del giornalismo italiano, che riflette su come affrontare la sfida informativa nell’attuale panorama culturale.
Il ruolo delle norme e delle piattaforme
Nel 2021, il Gruppo di lavoro su odio online del Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha pubblicato un report fondamentale che sottolinea l’importanza di non delegare esclusivamente alle piattaforme social il compito di moderare i contenuti. Una responsabilità così grande potrebbe comportare rischi importanti come la censura o la scarsa trasparenza.
Il documento propone invece un approccio più ampio, che include:
- La promozione dell’infodiversità, attraverso la valorizzazione di contenuti di qualità provenienti da scuole, biblioteche e musei;
- Lo sviluppo di nuove piattaforme della conoscenza, capaci di contrastare contenuti tossici;
- L’adozione di normative aggiornate all’ambiente digitale, considerate però uno degli strumenti tra i tanti da utilizzare per arginare il problema.
Verso una cittadinanza digitale consapevole
Accanto alla dimensione normativa, è fondamentale investire sulla consapevolezza digitale. Secondo il Manifesto per la Information Literacy dell’AIB, per orientarsi nel mondo online serve imparare a:
- Cercare e valutare le informazioni;
- Comunicare in modo etico e responsabile;
- Comprendere che anche il silenzio comunica, come sottolineato dal Manifesto della comunicazione non ostile.
Anche il nostro articolo sulle Nuove prospettive per il giornalismo nell’era digitale si interroga su come coltivare una cultura del rispetto e della responsabilità nella comunicazione contemporanea.
Gli strumenti per verificare: OSINT e Google Dorks
Nel mondo digitale, informarsi bene significa anche verificare le fonti. Ecco dove entra in gioco l’OSINT (Open Source Intelligence), cioè la raccolta di informazioni da fonti pubbliche e accessibili. Strumenti OSINT utilizzabili anche da giornalisti, educatori e cittadini includono:
- Google Dorks come
filetype:pdfper cercare documenti mirati su Google; - TinEye o la ricerca inversa di immagini per capire se una foto è già stata pubblicata;
- FotoForensics per rilevare se un’immagine è stata ritoccata;
- Archive.org, per visualizzare la cronologia di una pagina web, anche se cancellata o modificata.
Se ti interessa approfondire il contesto storico della professione giornalistica, puoi leggere anche il nostro articolo sulla Storia del giornalismo italiano e suo sviluppo nel corso del tempo, utile per comprendere l’evoluzione che ci ha portati all’era digitale.
Conclusione: informare, educare, reagire
Contrastare l’hate speech significa educare alla consapevolezza, informare con rigore e dotarsi di strumenti tecnici e culturali per riconoscere e disinnescare contenuti tossici. Significa, anche, parlare con gli intolleranti, come suggerisce il libro Odio pubblico, per creare una comunicazione aperta ma consapevole.
La sfida è culturale, educativa e collettiva. Solo con un approccio integrato – che unisca norme, tecnologia e alfabetizzazione digitale – potremo costruire un’informazione che sia davvero libera, pluralista e rispettosa.