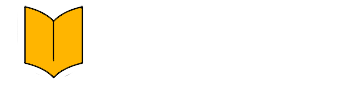Il fenomeno del linguaggio d’odio è diventato una delle principali minacce alla convivenza civile, alla libertà di espressione e alla tutela dei diritti umani nell’era digitale. Le espressioni cariche di ostilità e discriminazione si diffondono rapidamente online, alimentando stereotipi e intolleranza verso specifici gruppi sociali, spesso giustificate da presunti “liberi pensieri”. Ma come si riconosce l’hate speech, quali sono i suoi effetti e quali strumenti esistono per prevenirlo e contrastarlo?
Cos’è l’hate speech e quando costituisce reato
Il discorso d’odio, secondo il Consiglio d’Europa, è l’insieme di espressioni che incitano, promuovono o giustificano l’odio o la discriminazione verso individui o gruppi sulla base di razza, etnia, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere o altri fattori. In Italia, la Legge Mancino e altre disposizioni penali puniscono l’incitamento all’odio quando questo supera determinati limiti, trasformandosi in un reato perseguibile d’ufficio.
Tuttavia, esistono forme di discorso d’odio tossico, che pur non essendo illegali, sono estremamente dannose. Si tratta di espressioni cariche di pregiudizi e stereotipi che minano la coesione sociale e favoriscono un clima di intolleranza normalizzata.
Un concetto centrale è quello di odio intersezionale, che si manifesta quando una persona viene colpita per più caratteristiche identitarie contemporaneamente (es. essere donna, nera e omosessuale).
Per approfondire strumenti e strategie per contrastare questi fenomeni, leggi il nostro articolo su Hate speech, consapevolezza digitale e strumenti OSINT.
La piramide dell’odio: dalla parola alla violenza
Secondo la giornalista Silvia Garambois, il linguaggio d’odio va analizzato attraverso la piramide dell’odio, alla cui base troviamo pregiudizi e stereotipi apparentemente innocui. Salendo, si incontrano espressioni d’odio più esplicite, fino a giungere ad azioni discriminatorie, reati d’odio e, nei casi estremi, violenza fisica e crimini d’odio. Questa dinamica dimostra quanto sia importante intervenire tempestivamente sin dai primi segnali.

Un esempio concreto dell’impatto dell’hate speech riguarda le giornaliste, frequentemente bersaglio di attacchi sessisti, soprattutto sui social. Secondo l’inchiesta internazionale “Stop Violence Against Women Journalists”, condotta in 57 Paesi, le giornaliste sono tra le categorie più colpite da violenza verbale e intimidazioni digitali.
In Italia, la Mappa dell’Intolleranza elaborata da Vox Diritti ha rilevato che il 47,3% dei tweet negativi è rivolto alle donne. Per contrastare questi episodi, il Ministero dell’Interno ha istituito due strutture di monitoraggio e contrasto alle minacce verso i giornalisti.
Il ruolo della Polizia Postale nel contrasto all’odio online
La Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio del web per prevenire e indagare i crimini d’odio. Le attività si concentrano su contenuti pubblici e accessibili, senza la necessità di denunce formali, ma su segnalazioni provenienti da enti come UNAR e OSCAd. Le difficoltà più grandi derivano dal fatto che molti contenuti vengono diffusi tramite server localizzati all’estero, rendendo più complessa la rimozione o il blocco.
Il monitoraggio non si limita all’analisi del linguaggio: grazie a tecniche di OSINT (Open Source Intelligence), gli investigatori analizzano in tempo reale contenuti che possono sfociare in reati, tutelando così le persone più esposte.
Le iniziative europee e il ruolo della società civile
Il contrasto all’hate speech non può essere affidato solo alla repressione penale. A livello europeo, un importante passo avanti è stato fatto con il Digital Services Act, redatto dalla Commissione Europea, che impone obblighi più stringenti alle piattaforme digitali in termini di trasparenza e rimozione dei contenuti d’odio.
Nel panorama italiano, spicca il lavoro della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d’odio, una coalizione di realtà della società civile, attiva nella promozione dei diritti umani e della cultura dell’inclusione. A coordinarla è il linguista Federico Faloppa, che ha partecipato anche al Citizens’ Panel on tackling hatred in society della Commissione Europea.
Faloppa promuove un approccio culturale e formativo, sottolineando l’importanza di fare rete tra istituzioni, media, scuola e cittadini. Solo così è possibile prevenire davvero l’odio e costruire narrazioni alternative.
Il ruolo dei media e della responsabilità sociale
Un aspetto essenziale riguarda il ruolo dei media. La Raccomandazione 22 del Consiglio d’Europa invita gli operatori dell’informazione a promuovere inclusione e rispetto dei diritti umani, evitando contenuti sensazionalistici o polarizzanti.
Il giornalismo responsabile deve agire con etica e consapevolezza, non solo per informare, ma per contribuire attivamente alla prevenzione dell’odio. Anche la scuola, i musei, le biblioteche e i social media stessi possono essere strumenti di infodiversità, cioè di pluralismo informativo e costruzione di dialogo.
Contrasto all’hate speech
Il contrasto all’hate speech è una sfida complessa che riguarda tutti: istituzioni, cittadini, media, scuola, social network. Solo attraverso un approccio sinergico è possibile fermare la catena dell’odio. La prevenzione passa dall’educazione, dalla consapevolezza digitale e dalla capacità di riconoscere e denunciare contenuti tossici.
Agire contro il discorso d’odio non significa limitare la libertà di espressione, ma difendere la dignità umana. E questo, oggi più che mai, è un atto di responsabilità collettiva.